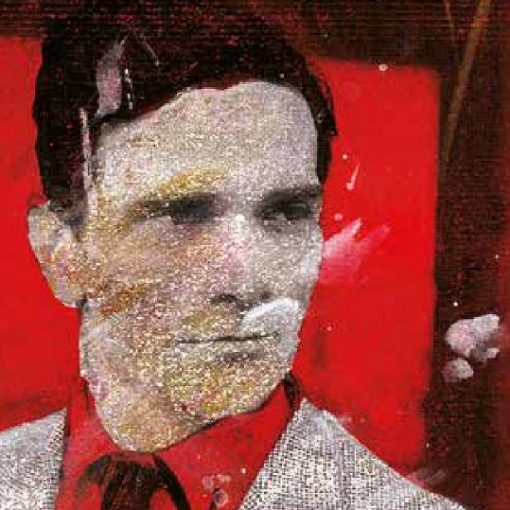L’opera di Verdi in scena all’Oper Köln dopo sessantasei anni Grandi protagonisti Petti, Torbidoni, Wakizono e Stavinsky Quatrini sul podio della Gürzenich. Delude la regia di Ben Baur
Succede tutto in un capannone. Estetica postindustriale, da regia “moderna”. Niente Gerusalemme, niente Babilonia, ma il nostro mondo distopico, alienante, opprimente. Succede tutto in un capannone. Unico luogo dello spettacolo, che uniforma Gerusalemme e Babilonia in un solo spazio, meglio, in un non-spazio che è abitato da un non-tempo. Grigio. Cemento armato e lamiera. Limbo di una società in cerca d’autore, con la gente condannata a vagare senza meta. Un hangar dove i segni del tempo e dell’usura sono evidenti. Tutto è in disfacimento, immagine fisica di una decadenza morale. Pareti pesanti che scorrono, si aprono e si chiudono. Inghiottono e vomitano gente. Una baracca – c’è anche una gabbia per i prigionieri, come quelle di Guantanamo o come quelle del circo, messa al centro perché tutti la vedano bene, monito tragicomico per gli oppressi – una baracca dove assembrare una grande folla. Impaurita. In balia degli eventi. In bilico sul futuro. Immagine di un mondo che uniforma, appiattisce, schiaccia. Interessante, raccontato così, Nabucco. Uno spazio – e qui, però, inizia a non tornare qualcosa – dove vincitori e vinti sono tutti insieme. Non si distinguono. Il libretto (lo scrive Temistocle Solera, sapienza antica, poesia che ha il sapore del tempo andato) dice, però una cosa diversa, definisce precisamente vincitori e vinti, li distingue, li contrappone e infine li affratella… «Immenso Jehovah, chi non ti sente?», preghiera a una sola voce di due popoli, vincitori e vinti (ma chi sarà davvero vincitore e chi vinto?), che si stringono in un abbraccio che sa di perdono.
Già il libretto, testo sacro come sacro è il testo musicale… il libretto qui, trascurato, spesso silenziato, guardato (letto) con tanta, troppa sufficienza… Il libretto che dice cose precise. Usa parole ognuna con un suo peso specifico. «O mia patria sì bella e perduta… o membranza sì cara e fatal…» poesia altissima. E una drammaturgia che vuole essere davvero efficace, in appiombo sul nostro presente, non può prescindere dalle parole – forse dalle didascalie sì, ma dalle parole no, mai, tanto che chi vuole farci sopra una drammaturgia propria le cambia, le sbriciola, le mette in bocca a chi non dovrebbe pronunciarle quelle parole (e ogni riferimento a Ilaria Lanzino e al suo scellerato, scriteriato, antiverdiano Nabucco di Düsseldorf è assolutamente voluta). Parole precise, narrative, sufficienti da sole per raccontare quelle di Nabucco. Non serve altro. Basta (basterebbe) “ascoltarle”. Certo, succede spesso che i registi (anche in Italia… dove la lingua dei libretti verdiani la si dovrebbe comprendere) prescindano dal libretto… che sarà mai una volta in più? Sì, ma non proprio. Ma mettiamo la questione da parte per un momento.
Dicevamo. Vincitori e vinti non si distinguono. Non si distinguono i piani temporali. E nemmeno quelli emotivi. Perché tutto è monocromo. Grigio. Anonimo. Informe. Tutto accade in un capannone. Grigio. Cemento armato e lamiera. Un luogo della memoria. E la memoria va subito ad un’altra Memoria, quella dell’Olocausto, certo associazione facile e scontata, vista e rivista, usata e ab-usata, quando in locandina c’è Nabucco. Il Nabucco di Giuseppe Verdi che racconta della deportazione degli ebrei a Babilonia nel 597 a. C., non quella che scientificamente mise in atto Hitler, deportazione e sterminio, nei campi di concentramento. Dove c’erano tanti capannoni, come quello che si vede sul palco della Saal 1 dello Staatenhaus, la “casa” temporanea (ancora per quanto? all’orizzonte si fatica a vedere la fine del cantiere della sede storica di Offenbachplatz) dell’Oper Köln. Cifra estetica – unica cifra, perché una vera drammaturgia non c’è e dove c’è (o dove vorrebbe esserci) è molto confusa, antiverdiana – del Nabucco del regista (e scenografo) Ben Baur. Tutto dentro un capannone questo Nabucco, nuova produzione, attesissima, del titolo verdiano che mancava da Colonia da sessantasei anni. Troppi, perché Nabucco è un titolo imprescindibile, di quelli che ha segnato uno degli snodi della storia della musica, come l’Orfeo di Claudio Monteverdi, come Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart, come Elektra di Richard Strauss, come Wozzeck di Alban Berg. Dopo Nabucco niente è più come prima nella storia.
E a Nabucco ci si deve tornare periodicamente. Per capirlo. Per farne memoria. Bentornato Nabucco, allora, in una nuova, eccellente produzione sul fronte musicale. Un Nabucco di voci. Voci verdiane, quella di Ernesto Petti, velluto ed emozione a fior di pelle, quella di Marta Torbidoni, lama di luce e carezza, quella di Aya Wakizono, abbraccio e sferzata, quella di Evgeny Stavinsky, autorevolezza e consolazione, quella di Young Woo Kim, squillo e malinconia. Voci verdiane. Voci “da” Nabucco. Partitura che dal podio Sesto Quatrini restituisce insieme alla Gürzenich Orchester accentuandone più il respiro sinfonico che quello patriottico – sarà interessante vedere la cifra che imprimerà Giulio Cilona, direttore d’orchestra interessantissimo, che raccoglierà il testimone (la bacchetta) da Quatrini dal 26 dicembre. La Gürzenich è una grande orchestra sinfonica e sbalza molto bene la scrittura verdiana che è canto, certo, ma anche trama sinfonica raffinatissima. E lo fa con un suono “tedesco” (un Nabucco che ha fatto la storia è quello “tedesco” di Giuseppe Sinopoli e il suono della Gürzenich rimanda a quelle atmosfere). Un suono dai contorni più netti che avvolgenti, forse anche per la strana acustica della Saal 1 dello Staatenhaus dove l’opera tedesca “corre” mentre quella italiana sembra, a volte, arrivare a due dimensioni. Un Nabucco sinfonico. Tempi ampi, oasi di meditazione nella direzione di Quatrini come il «Vieni o Levita» di Zaccaria (qui c’è già il Verdi della grande scena di Filippo II del Don Carlo, ma anche certe atmosfere notturne di Falstaff), il «S’appressan gl’istanti», squarci spirituali come l’«Immenso Jehovah» per un Nabucco meditato e interiore. Un Nabucco corale, quello del quarantenne direttore d’orchestra romano grazie alla grande prova del Chor der Oper Köln di Rustam Samedov, colore verdiano, accento sempre giusto.
Un Nabucco di voci. Che vincono su tutto. La voce di Ernesto Petti che ha la morbidezza del velluto e la robustezza della roccia. E ha la sapienza antica, la consistenza della corteccia e del tronco dell’albero, accumulo di storia, radici nel passato e rami protesi al futuro. Come il suo Nabucco, granitico nell’imporre il suo potere, ma fragile, dolente quando dietro la maschera del condottiero si rivela il volto del padre. Toccante il «Deh perdona», intenso il «Dio di Giuda» che il baritono campano, con il suo strumento vocale bellissimo, tra i più belli di oggi, restituisce con un accento verdiano e un’emozione a fior di pelle che catturano e commuovono. Capace, Petti, di far diventare carne e fiato la musica di Verdi, di farla vivere e di farla dialogare (cosa necessaria perché l’opera non sia museo) con il nostro presente. Marta Torbidoni è in simbiosi con Abigaille. Ha fatto suo il personaggio che restituisce non con il taglio wagneriano che alcuni vorrebbero per la figlia adottiva di Nabucco (nel secondo cast a Colonia c’è la wagneriana Trine Møller che, però, piega il suo strumento alla scrittura verdiana), ma sbalzando il belcanto che Verdi (titolo di svolta Nabucco, ma è pur sempre il Verdi degli inizi) mette nella sua partitura: colorature sempre a fuoco, acuti timbratissimi e lucenti, lame che illuminano il buio, affondi (la voce del soprano marchigiano sale e scende con una facilità impressionante, sempre piena, corposa…) che avvolgono. Un’Abigaille dark (così la vuole il regista, la veste di nero e pelle Julia Katharina Berndt, che disegna costumi moderni, tutti dal bianco al nero passando per cinquanta sfumature di grigio) Abigaille che alla fine sa toccare le corde più intime.
Aya Wakizono è una Fenena presentissima, sempre musicale, sempre capace di respirare con chi le sta intorno, una voce che abbraccia e che al momento giusto sa sferzare, con un colore brunito che all’improvviso si illumina. Zaccaria ha l’autorevolezza vocale e scenica di Evgeny Stavinsky, russo della regione di Mosca (e un po’ si sente, ma non come si sentiva nei bassi di un tempo, cavernosi e cupi), capace di dare al Pontefice degli ebrei un’inaspettata doppiezza, consolatorio, ma anche minaccioso. Autorevole come è autorevole e ben centrato il Gran Sacerdote di Belo di Lucas Singer. Torrenziale l’Ismaele di Young Woo Kim, voce che è un fiume in piena che si riversa sulla platea, musicalissimo in uno squillo sempre luminoso e antico che sa colorarsi di malinconia. Abdallo è John Heuzenroeder, Anna (alla quale il regista affida la lettura di Einem Feldherrn, della poetessa austriaca Ingeborg Bachmann in apertura della quarta parte…) è un’incisiva Claudia Rohrbach. Voci antiche e al tempo stesso nuove. Come quelle del cast che si alterna nelle tante recite in programma, il Nabucco musicalissimo e umanissimo di Stefano Meo, la spigolosa Abigaille di Trine Møller, la convincente Fenena di Adriana Bastidas-Gamboa, lo Zaccaria autorevole di Simón Orfila e l’efficace Ismaele di Vasyl Solodkyy insieme al Gran Sacerdote di Belo di Christoph Seidl e all’Abdallo di Armando Elizondo.
Voci antiche e al tempo stesso nuove, modernissime nel raccontare chi sono oggi Nabucco, Abigaille, Fenena, Zaccaria ed Ismaele. Cosa che non fa lo spettacolo “nuovo” di Baur. Nuovo, messo tra virgolette. Perché uguale (e allora perché proporlo? quale l’urgenza, la necessità di un “nuovo” che in realtà è un già visto?) uguale a tanti troppi Nabucco che catapultano le vicende del re babilonese in un Novecento distopico o in un passato prossimo di deportazioni e campi di concentramento – quello di ricci/forte al Festival Verdi di Parma, quello di Daniele Abbado al Teatro alla Scala, quello di Marcos Darbyshire a Mainz…. Riferimenti che, se non sono così evidentemente chiassosi nell’allestimento di Baur (ci sono comunque spogliazioni di massa, cumuli di abiti, gabbie e catene…), certo si vedono in controluce. Nel grigio che domina tutto. In quel capannone (illuminato da Nicol Hungsberg) dove tutto succede, luogo della memoria dove rivivere perennemente la stessa storia. Storia di abusi di potere, di deportazioni, di morte. Ma anche (e forse soprattutto) storia di redenzione e di perdono. Storia di conversione. Che può anche essere letta in un altro modo… certo il libretto dice quello, chiaramente… «Dio di Giuda… adorarti ognor saprò»…, ma se proprio non vuoi fare un discorso spirituale hai mille altre possibilità… Storia di conversione che potrebbe essere trasfigurata (compito che da sempre è affidato alla regia) con una drammaturgia capace di catapultarti improvvisamente nel nostro presente con parole che “dicono”, cantano personaggi di un passato che solo a pensarlo fa venire le vertigini. Allora Nabucco potrebbe essere la storia di una conversione alla pace. Necessaria. Urgente. In questo nostro mondo grigio, distopico, alienante, opprimente. Mondo in guerra.
Ma la guerra che Ben Baur racconta, sullo sfondo di un mondo distopico e dittatoriale visto e rivisto quando in locandina c’è Nabucco, non è, per dirla con Papa Francesco, la «terza guerra mondiale a pezzi» che affligge il nostro presente. Ma è una guerra familiare. Una faida. Lotta tra sorelle, Abigaille e Fenena che si contendono la corona di Nabucco. Lotta per il potere che ha il sapore di una serie tv, senza esclusione di colpi. E alla fine non si salva (quasi) nessuno in questa faida familiare. Da libretto muore solo Abigaille. Ma qui Nabucco uccide con un colpo di pistola il Gran Sacerdote di Belo (sarebbe l’Idolo infranto che crolla a terra… e appunto resta lì stecchito…). Abigaille si avvelena bevendo quello che sembra uno spritz. Che poi offre a Fenena che morirà anche lei, tra convulsioni atroci proprio mentre Nabucco viene ucciso, pugnalato da Zaccaria (pericoloso in questo 2024 mettere in scena un ebreo che uccide uno che oggi abiterebbe in Iraq…) che pronuncia il suo «Servendo a Jehovah sarai de’ regi il re», anche se non si capisce a chi lo dica… E sono tanti i perché che restano senza risposta.
Abigaille nella sua grande aria esordisce «Ben io t’invenni o fatal scritto…» che tradotto vuol dire «per fortuna ho trovato questo documento importante…». Lo trova lei, dice il testo. Qui invece è Nabucco (che stando a quello che canta Abigaille dovrebbe essere «tra l’armi a sterminar Giudea l’animo intende», ma è lì con lei) che lo consegna alla stessa Abigaille in una scena senza musica che precede l’inizio della seconda parte. Perché? Così qualcosa non torna e non torna il duetto del terzo atto dove Nabucco crede di rivelare ad Abigaille il fatto che lei non è sua figlia, ma figlia di schiavi, ma in realtà glielo aveva già detto prima consegnandole quel foglio. Stessa scena. Altra cosa che non torna. I sacerdoti che accompagnano il Gran Sacerdote di Belo e che con lui hanno organizzato il “colpo di stato” per togliere il potere a Fenena e darlo ad Abigaille dovrebbero essere alleati della donna, ma qui sono prigionieri, incappucciati, che lei tortura uccidendone addirittura uno… ma perché? Sarà perché lei sta cantando «salgo già del trono aurato lo sgabello insanguinato»?
Scene che confluiscono l’una nell’altra in dissolvenza, ma è drammaturgicamente sbagliato perché Verdi mette cesure temporali e soprattutto emotive tra una parte e l’altra. Le chiama parti, non atti. Icone, stazioni di una vicenda, quella di Nabucco, che ha una sua parabola ben precisa. Tanto che non funziona la scelta di fare un intervallo (il solo della serata, non se ne possono fare tre, altrimenti sarebbero più lunghe le pause della musica) dopo la prima parte. Interrompe il racconto (anche emotivo) della parabola folle di Nabucco, quella che si spezza alla fine della seconda parte (qui andava messo l’intervallo) quando delira «non son più re, son dio». È dalla terza parte, nuovo capitolo, nuova stazione del cammino di Nabucco, che inizia la conversione, la presa di coscienza e la richiesta di perdono (e di pace) al Dio di Giuda – l’idea di lasciare Nabucco in scena, chiuso in gabbia durante il Va’ pensiero è bella, suggestiva, evoca, suggerisce il germe della conversione… che però poi non si compie. Perché alla fine non si salva nessuno. C’è solo una faida famigliare che finisce in carneficina. Nabucco uccide il Gran Sacerdote di Belo, Abigaille si avvelena e avvelena Fenena – ma qui perde di senso l’arioso di Abigaille (grande zampata del genio musicale e teatrale di Verdi che fa uscire di scena la diva con un arioso e non con una scena alla Rossini o alla Donizetti o alla Bellini) che chiede che «su me, morente, esanime, discenda il tuo perdono… Fenena io fui colpevole… Or chi mi toglie al ferreo pondo del mio delitto… Te chiamo o Dio, te venero… Non maledire a me…».
Così dice il libretto. Ma l’impressione, di fronte alle tante, troppe incongruenze del racconto è che il libretto sia stato messo da parte e si sia imbastito lo spettacolo su un riassunto della trama. Impressione che avverti anche dai tagli disseminati nella partitura, alcuni microscopici, altri più evidenti che vanno contro la musica. Il più antimusicale quello della cabaletta di Nabucco della quarta parte, «O prodi miei, seguitemi», una manciata di battute tagliate che avrebbero “allungato” la serata di pochi secondi… Tagli. Altrove, invece, ripetizione (e la lettura della poesia della Bachmann) perché necessarie ai movimenti e ai cambi di scena. Anche se tutto avviene in un capannone. Un mondo a parte nel quale è difficile (avranno voluto dire questo i dissensi, forse eccessivi, che misti agli applausi hanno accolto Ben Baur alle uscite finali la sera della prima) nel quale è difficile vedere riflesso il nostro. Mondo, il nostro, che Verdi, ancora oggi, ci sa raccontare. Basta ascoltarlo.
Nelle foto @Thilo Beu Nabucco all’Oper Köln