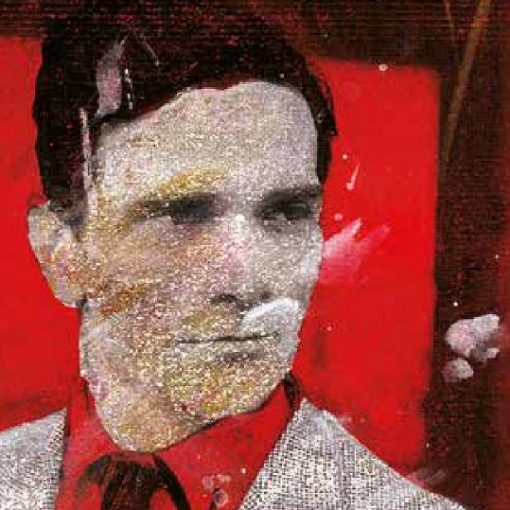All’Opera di Roma intensi Capuleti e Montecchi di Bellini restituiti con disarmante bellezza dal direttore milanese Un Novecento di lotte fratricide nella regia di Denis Krief
Quando all’inizio, con le note della sinfonia ancora nell’aria, si alza il sipario siamo già nel mezzo della storia: il patatrac è fatto perché Romeo e Giulietta, figli di due famiglie in guerra, si sono già innamorati. Il nodo che nella tragedia di William Shakespeare accende la miccia del racconto e porta, inevitabilmente, al drammatico finale è già stretto: qui, quando inizia la musica di Vincenzo Bellini, il «Romeo perché sei tu Romeo» è già stato detto, il bacio dato e richiesto indietro sotto il balcone è già scoccato. Si evita così quella sdolcinatezza che, diciamocelo, rischia di fare del racconto shakespeariano un’immagine buona per le scatole di cioccolatini da regalare a San Valentino. Sdolcinatezza che, forse, nessuno di quelli che hanno tradotto in teatro o in musica o in pittura la vicenda degli amanti di Verona è riuscito ad evitare almeno in parte.
Ma a Bellini e al suo librettista Felice Romani non interessava confezionare una love story in musica, piuttosto raccontare il risvolto politico (che può essere ancora tremendamente attuale) della vicenda che in Shakespeare rimane (pur restando drammaturgicamente cruciale) sullo sfondo. E il titolo non è un calco di quello del drammaturgo inglese, non è l’ennesimo Romeo e Giulietta, tanto più che il libretto non è una riduzione della tragedia (Lorenzo non è frate, ma medico, Giulietta non è promessa a Paride, ma a Tebaldo…), ma un nuovo lavoro ispirato a novelle e racconti letterari sui due amanti. L’opera si intitola I Capuleti e i Montecchi, scelta che mette in campo da subito, ben chiari, i contendenti: due fazioni, due bande rivali, il clan di Romeo e quello della famiglia di Giulietta, guelfi e ghibellini che in diverse città d’Italia si fronteggiavano (il libretto colloca l’azione nella Verona del tredicesimo secolo).
Inquadramento teorico (lungo) per dire che sarebbe sbagliato sedersi in platea per I Capuleti e i Montecchi di Bellini e aspettarsi uno svolgersi del racconto sul modello shakespeariano. Occorre sgombrare il campo e prepararsi ad assistere a un’altra storia. Un’altra storia che al Teatro dell’Opera di Roma non è solo drammaturgica. È prima di tutto musicale perché sul podio c’è Daniele Gatti. E quando il direttore d’orchestra milanese – guida stabile dell’Opera – apre una partitura e la mette sul leggio è sempre “un’altra storia”: per lo scavo profondo nel testo musicale, per la capacità di (ri)leggere ciò che si conosce da tempo – l’opera scritta nel 1829 debutta nel 1830 – e restituirlo in un modo nuovo, sorprendente e inaspettato. Grandezza dell’artista che ha qualcosa a dire di non scontato e di scomodo, perché tale deve essere l’arte se vuole interrogare il nostro tempo.
Questa volta il musicista fa tutto questo con il belcanto di Bellini. E, viene da dire,: non c’è storia. Perché la bellezza disarmante della direzione di Gatti, la sua intelligenza musicale trasfigura ed esalta la scrittura del compositore catanese astraendola da qualsiasi incrostazione storica, di tradizione o (peggio) caricaturale per farne musica pura e assoluta. Non c’è storia perché questo Bellini è radicalmente nuovo nelle dinamiche, nelle atmosfere, nel fare di canto e musica un unico impasto. Gatti ribalta così la prospettiva con la quale solitamente si affronta il belcanto mettendo al centro l’orchestra (e quella dell’Opera, in costante crescita, suona perfetta con le belle prove di corno, clarinetto e violoncello ai quali sono affidati importanti assoli): la vuole protagonista e non solo tappeto sonoro che prepara e accompagna/sostiene il canto perché il racconto parte e si compie sempre in orchestra.
Il direttore ti avvolge con una melodia che ammalia nella dilatazione dei tempi, che toglie il fiato nelle strette vertiginose dei finali, che nella scena che chiude il dramma è già proiettata prepotentemente verso un Novecento (amato e frequentato dal direttore) dove parola e musica si spogliano di ogni orpello per farsi teatro prima e vita poi. Un finale, che è la cosa che assomiglia più a Shakespeare, che sentito così ti lascia anche inquieto di fronte al dramma di Romeo e Giulietta. Che sono le eccellenti Vasilisa Berzhanskaya e Mariangela Sicilia, mezzosoprano la prima, soprano la seconda. Una conferma, la Sicilia, per la voce di cristallo che la cantante governa con una tecnica solida e riveste di gusto raffinato. Una scoperta la Berzhanskaya, voce morbida e pastosa e di bellissimo colore, capace di cantare timbratissima in basso e arrivare all’acuto luminoso con una facilità impressionante. Intense nelle arie, affiatate nei duetti, le due interpreti (credibili anche scenicamente) hanno accanto una compagnia (piccola, Bellini prevede solo cinque personaggi) di livello: Tebaldo ha lo squillo tenorile di Ivan Ayón Rivas, a Lorenzo offre ombre e ripiegamenti Nicola Ulivieri mentre Cappellio, padre di Giulietta, ha volto severo e voce ferma di Alessio Cacciamani. Gatti plasma il coro di Roberto Gabbiani e lo vuole cameristico, mai battagliero, misurato e con un afflato tutto interiore, anche nei proclami di vendetta che sono il ritornello di uno spettacolo (e prima di una partitura) politico.
Lo firma interamente Denis Krief – sue regia, scene, costumi e luci – che riprende per Roma il suo allestimento del 2005 andato in scena a Martina Franca. Politico perché prova a rileggere le vicende de I Capuleti e i Montecchi avvicinandoceli nel tempo, mettendo in scena un Novecento di lotte partigiane (la scena chiusa da archi è lignea ed è attraversata da una trincea di filo spinato) dove gli uomini imbracciano i fucili e le donne – che poi è solo una, Giulietta – sono merce di scambio e non possono sognare un futuro di libertà, nemmeno davanti a un abito da sposa che, posto su un manichino, diventa camicia di forza, incubo dal quale provare a fuggire. Krief parte dalla convinzione che Bellini e Romani non guardano a Shakespeare, cerca di evitare gli stereotipi della tragedia (ma perché vestire da prete Lorenzo che in Shakespeare, certo, è un frate, ma nel libretto di Romani è un medico?) per raccontare la quotidianità di una festa di matrimonio (tavoli e sedie e bicchieri da osteria) interrotta a più riprese dalla guerra. Inutile strage, dice Gatti rendendo nostra contemporanea la musica di Bellini.
Nelle foto @Yasuko Kageyama I Capuleti e i Montecchi all’Opera di Roma